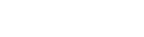Adozione e affidamento
“La nostra vita con te inizia ora, la tua inizia per la seconda volta”
(Giacomo Micheletti)
Bambini adottati e teoria dell’attaccamento
Per capire cosa succeda ad un bambino adottato, come mai possa essere così difficile relazionarsi a lui, o perché possa accadere che, dopo l’inserimento nella nuova famiglia, le attenzioni e le cure ricevute da parte dei genitori adottivi non sembrino sufficienti, è utile riferirsi alla teoria dell’attaccamento.
Abbiamo visto in precedenza come l’attaccamento sia un sistema comportamentale e motivazionale, biologicamente determinato, che spinge il bambino a cercare la vicinanza e il conforto di una figura percepita come “più forte e/o più saggia” (Bowlby, 1979), nei momenti in cui il piccolo si sente spaventato, confuso, ansioso o angosciato.
Sulla base della sua interazione con l’ambiente e con i suoi caregiver, poi, ogni bambino costruisce dei Modelli Operativi Interni (MOI), ossia delle rappresentazioni interne di sé e delle figure di attaccamento: modelli di sé-con-l’altro (Liotti, 2001), cioè della relazione.
A partire da tali modelli rappresentazionali, dunque, il bambino si crea una mappa interna del suo mondo relazionale, in grado di guidare la percezione e l’interpretazione degli eventi: tale mappa, quindi, gli consentirà di fare previsioni e sviluppare aspettative in merito alle proprie interazioni con l’ambiente e con gli altri.
È bene ricordare che, una volta costruiti, i Modelli Operativi Interni tendono ad essere relativamente stabili nel tempo e ad autoperpetuarsi; inoltre, sono in genere utilizzati in maniera automatica e non consapevole.
Quanto detto in precedenza contribuisce a spiegare l’insieme di comportamenti mostrati dai bambini, sia nelle situazioni di adozione sia in quelle di affidamento temporaneo.
Diviene chiaro, infatti, come le primissime relazioni di un bambino possano condizionare la qualità di elaborazione delle informazioni e le sue future relazioni affettive, nel corso di tutta la vita.
Il fatto che i MOI siano adoperati in maniera automatica e non consapevole, inoltre, può costituire uno svantaggio nel caso in cui si verifichino, nell’ambiente circostante e nella vita relazionale del bambino, cambiamenti che gli richiedono una modifica della sua mappa interna: se i Modelli Operativi Interni del bambino hanno acquisito un carattere di rigidità (come sovente avviene nel caso degli attaccamenti insicuri e disorganizzati), possono manifestarsi alcune difficoltà.
Può accadere, dunque, che i bambini continuino a utilizzare, nella relazione con i genitori adottivi, la strategia di attaccamento (e il conseguente Modello Operativo Interno) appreso nella disfunzionale famiglia di nascita; se però tale strategia poteva essere considerata in certa misura adattiva in risposta alle situazioni patologiche caratterizzanti il nucleo familiare di origine, nella famiglia sostitutiva si rivela disfunzionale.
Comprendere le esperienze traumatiche
Quando ci si relaziona ai bambini adottati, è importante ricordare che essi possono essere stati esposti a esperienze precoci particolarmente traumatiche.
Molti bambini destinati all’adozione, infatti, sono stati sottratti alle loro famiglie d’origine a causa di maltrattamenti, e mostrano spesso esperienze di estrema trascuratezza, abuso fisico, psicologico, sessuale e/o emotivo, o ancora di perdita, abbandono, separazioni multiple.
Nel corso del suo sviluppo, ogni bambino impara a gestire e ad organizzare le proprie esperienze. Gradualmente, apprende concetti e categorie all’interno dei quali collocare gli eventi, le emozioni, i pensieri: in tal modo, è in grado di valutare ciò che succede dentro e intorno a lui, di attribuirgli un significato e di elaborare modalità e strategie per fronteggiare le situazioni, acquisendo così un senso di autoefficacia e sicurezza.
Perché tutto questo avvenga, però, è necessario che ci sia una certa prevedibilità e stabilità nell’ambiente e negli affetti che fanno parte della vita del bambino, e che le sue figure di attaccamento primarie (caregiver) siano in grado di offrirgli la protezione e le cure di cui necessita.
Abbiamo già detto come molto spesso i bambini destinati all’adozione provengano da famiglie disfunzionali, trascuranti e/o violente: in tali famiglie, i caregiver del bambino non sono in grado di aiutarlo a gestire la paura, l’ansia o la confusione; anzi, spesso sono essi stessi la causa di tali sensazioni negative. Accade così che il piccolo sperimenti sensazioni di angoscia soverchiante e ingestibile, perché messo di fronte a un paradosso senza soluzione: le sue figure di attaccamento, i suoi caregiver, sono (o dovrebbero essere) fonte di conforto e, allo stesso tempo, di una paura imprevedibile.
Il bambino, così, fa esperienza di quella che è stata chiamata paura senza sbocco (fright without solution; Main e Hesse, 1990): tale paura impedisce di elaborare le esperienze in maniera coerente e di acquisire la capacità di modulare emozioni e comportamenti, e può portare il bambino a sviluppare una disorganizzazione dell’attaccamento.
Poiché spesso i bambini adottati hanno vissuto traumi di questo genere, dunque, bisogna sempre tener presente che il loro comportamento, anche nel qui ed ora, deriva dalla paura che hanno sperimentato precocemente, nelle loro relazioni con la famiglia di origine.
Come si può aiutare un bambino con questa storia?
Per aiutare il bambino a passare da una condizione di spavento e angoscia a una di sicurezza, è necessario che chi si prende cura di lui gli fornisca non solo affetto e cura, ma anche che comprenda cosa il bambino ha sperimentato (e ancora sta sperimentando), al fine di aiutarlo a rielaborare le proprie esperienze e a far sì che sviluppi la capacità di interpretare e rispondere appropriatamente alle situazioni e agli stimoli.
Trauma e risposta allo stress
Per avere una comprensione più ampia di cosa accade ai bambini adottati, o di come le loro esperienze precoci, spesso estremamente difficili, possano aver ostacolato uno sviluppo sano, è utile conoscere quali sono i meccanismi biologici e fisiologici che regolano la risposta allo stress.
Cosa succede, dunque, quando si è in presenza di un evento minaccioso e spaventante?
Secondo il modello di Porges (Porges, 2007) in situazioni di pericolo e paura il sistema vagale ventrale, attivo nelle condizioni di sicurezza, viene disattivato, ed entra in azione il sistema simpatico: l’organismo, cioè, attiva un sistema primitivo per reagire allo stress il più rapidamente possibile, preparando quelle che sono state chiamate risposte di fight-or-flight (attacco o fuga).
Tale attivazione, che coinvolge il sistema nervoso autonomo e l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, comporta un massiccio rilascio di catecolamine e di cortisolo (il cosiddetto ormone dello stress), la concentrazione dell’attenzione sulla fonte della minaccia, iper-vigilanza e iper-attivazione neurovegetativa (hyper-arousal): aumentano così la frequenza cardiaca e respiratoria, la pressione arteriosa e il tono muscolare.
Nel primo anno di vita, va notato, i bambini non possono portare a compimento la risposta di attacco o fuga, a causa dell’immaturità delle loro funzioni motorie. Più in generale, per un bambino molto piccolo lottare significherebbe soccombere, e fuggire vorrebbe dire allontanarsi dalle figure di attaccamento: in entrambi i casi, dunque, sarebbe minacciata la sopravvivenza. Pertanto, in presenza di stress cronici e ripetuti, in cui la figura di attaccamento non è in grado di fornire protezione al bambino, o quando essa stessa è fonte di minaccia, si apre la strada della dissociazione, che passa per la reazione d’immobilità fisica come difesa estrema (Tagliavini, 2011).
Se infatti l’attivazione del sistema simpatico non basta ad assicurare una risposta di sopravvivenza, perché la minaccia è soverchiante, entra in azione il ramo dorsale del nervo vago, che inibisce l’ortosimpatico (hypo-arousal) fino a poter procurare una condizione nota come sincope vagale, o “finta morte”. La finta morte è una reazione estrema al pericolo, selezionata nell’evoluzione per il vantaggio che talora può offrire quando fuga e lotta di fronte a un animale predatore sarebbero inutili: con il tono muscolare ridotto al minimo, la frequenza cardiaca e respiratoria tanto diminuite che il torace appare immobile, così come il resto del corpo, la preda può apparire morta al predatore prima che la attacchi – guadagnando così un’ultima possibilità di sopravvivenza.
Questa strategia di risposta conferisce dunque un vantaggio nelle situazioni traumatiche a cui è impossibile sfuggire, e in cui ogni lotta sarebbe vana. Il risultato estremo di tale strategia di attivazione dorso-vagale è, però, la dissociazione, con disconnessione tra la corteccia prefrontale e le strutture sottocorticali: l’iper-attivazione dell’amigdala (che gestisce le emozioni e, soprattutto, la paura) non viene inibita, lo stimolo rimane non elaborato e diventa così una memoria traumatica isolata, non integrata con il resto delle esperienze e delle conoscenze, come è ben dimostrato da studi effettuati con la risonanza magnetica funzionale (Lanius, Williamson e al., 2005; Schore, 2009).
L’attaccamento disorganizzato deriverebbe proprio da questi processi dissociativi ripetuti, che impediscono al bambino di sviluppare fiducia in sé e nelle relazioni con gli altri e che lo portano alla disregolazione emotiva (Farina e Liotti, 2011).
Per capire come mai, in seguito all’esposizione a condizioni di stress o di traumi ripetuti, si possano produrre delle risposte disregolate, anche di fronte a stimoli di lieve entità, è utile riferirsi anche alla teoria di Siegel relativa a quella che è stata chiamata “finestra di tolleranza”.
Con il concetto di “finestra di tolleranza” l’autore si riferisce a un grado di attivazione emotiva e fisiologica (arousal) che garantisce all’individuo condizioni ottimali per un buon funzionamento; collocata tra gli estremi dell’hypo– e hyper–arousal, tale finestra di tolleranza può essere concettualizzata come una zona all’interno della quale “le varie intensità dell’attivazione emotiva e fisiologica possano essere elaborate senza disgregare il funzionamento individuale” (Siegel, 1999). Tale grado di attivazione ottimale varia da individuo a individuo e si modifica, in maniera plastica, in base alle esperienze. Molto spesso, in presenza di una storia traumatica, il soggetto fa esperienza di situazioni di eccessiva attivazione (hyper-arousal), o di attivazione troppo bassa (hypo-arousal), che non gli permettono di integrare ed elaborare le esperienze in maniera coerente. Condizioni di stress prolungato possono modificarel’ampiezza dello spettro della finestra di tolleranza, portando il soggetto a produrre risposte disregolate anche in presenza di situazioni sicure.
Uno degli obiettivi iniziali, dunque, dev’essere quello di far acquisire al bambino la capacità di regolare tali strategie di risposta nelle sue interazioni interpersonali.Perché questo possa avvenire, è necessario comprendere quali sono gli attivatori delle risposte di paura, e quali i segnali che precedono la disregolazione. In tal modo, si potrà supportare il bambino nello sviluppo di strategie per sentirsi calmo, regolato e sicuro: l’obiettivo dovrà essere quello di guidarlo nell’imparare a modulare i suoi stati di disregolazione, elaborando le esperienze traumatiche, in modo che possa di nuovo ampliare lo spettro della sua finestra di tolleranza e acquisire così la capacità di autoregolare i propri stati fisiologici, emotivi e cognitivi.
E’ stato visto come esperienze traumatiche in età evolutiva possano incidere negativamente sulla capacità di riconoscere le emozioni altrui e che i bambini che hanno subito maltrattamenti in età precoci siano portati a decodificare e rispondere maggiormente all’emozione della rabbia, come se il loro sistema neuro vegetativo fosse sempre in allerta per proteggerli da eventuali pericoli.
I bambini che hanno subito abusi o violenza tendono inoltre ad interpretare negativamente espressioni facciali neutre, riescono a riconoscere più velocemente emozioni di rabbia o tristezza. Questa attenzione selettiva ha un duplice risvolto negativo sul benessere del bambino: da un lato infatti i livelli di stress conseguenti ad una continua attivazione su cues negativi rimangono costantemente elevati causando un sovraccarico al SN, dall’altro, la possibilità di concentrarsi su eventi piacevoli sia interni che esterni si riduce notevolmente innescando così un circolo vizioso che può diventare estremamente lesivo per lo sviluppo psicologico del bambino.
L’Italia ha dato un’importante contributo, soprattutto negli ultimi anni, grazie all’utilizzo delle tecniche di neuro immaging che hanno consentito di approfondire i correlati neurobiologici del trauma e soprattutto dell’efficacia del trattamento EMDR su pazienti traumatizzati.
Di recente in Italia, grazie alla collaborazione tra istituti pubblici e privati, è stato pubblicato uno studio che ha fornito un ulteriore contributo alla ricerca scientifica sull’efficacia del trattamento EMDR sui bambini (Trentini et al., 2015).
In questo studio, sono state presentate delle immagini di espressioni facciali ad alto contenuto emotivo prima e dopo il trattamento con EMDR a bambini traumatizzati: dopo il trattamento è stato rilevato un incremento dell’attivazione delle aree deputate al processamento cognitivo superiore e questi cambiamenti erano associati ad una diminuzione della sintomatologia depressiva e al miglioramento delle capacità di adattamento alle situazioni stressanti.
Anche in questo caso il trattamento con Emdr si è dimostrato efficace e gli effetti della rielaborazione del passato hanno una ricaduta positiva nella capacità del bambino di discriminare tra presente e passato, e distinguere tra pericolo reale e immaginario .